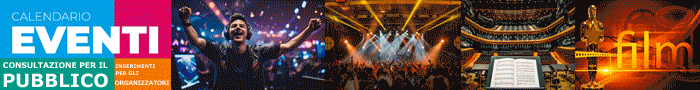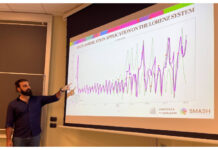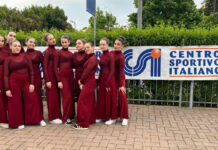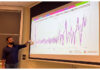Appello ai comuni “fantasma” di Lecce e alle anime artistiche delle nuove generazioni
(di Martina D’Elia)
Un tale, un certo Holden, un giovane tipetto ribelle e depresso, un giorno disse: “Se davvero avete voglia di sentire questa storia, magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e com’è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io, e tutte quelle baggianate alla David Copperfield, ma a me non va proprio di parlarne.”
Non so voi, ma io non mi sento poi così lontana da un tipo vissuto un centinaio d’anni prima di me. Non ho voglia di parlare, parlarne, comunicare. Mi va di bere, questo sì. Mi va di dimenticare. Dimenticare cosa, mi direte. Hai un tetto sicuro, una testa per ragionare, sogni nell’armadio (perché il cassetto è ormai troppo piccolo per contenerli). Cosa vuoi dimenticare, mi direte, cosa ti manca, se possiedi più di quello che i tre quarti della popolazione può permettersi.
Vi dirò: mi manca la terra sotto i piedi. Mi manca la possibilità. Anzi, a dir la verità, mi manca la voglia di averla, una possibilità. Ma perchè? Perchè?
Finirai come quel tipo, mi direte (forse era Dostoevskij, forse non so), che diceva che a distanza di anni avrebbe ricordato che in quel determinato posto del suo paese aveva avuto ricordi felici, anche se in quel momento preciso non lo avrebbe mai detto. Lo dirai seduto sul letto del tuo monolocale a Bologna, mi direte, tra una partita a Call of Duty e un’altra, la camicia da cameriere (un lavoro che odi) gettata in un angolo, preso dalla nostalgia della tua terra.
“Eh, a Piazza Ferrari, così si chiama, a quei tempi mi nascondevo con la mia ragazza – il mio primo amore – per non farmi vedere dai miei. E fumavamo e ci baciavamo mentre l’estate finiva.”
“C’era una festa di paese – di San Francesco, la chiamavano – ecco, quei primi giorni di giugno li ricordo sempre così caldi. Volevo andare a vedere i cavalli, ma mia madre si attardava alla bancarella della frutta perché era lì che vendevano le prime ciliegie dell’anno”.
Mi manca la possibilità di essere presa sul serio, vi dirò. E non vi mento quando, ubriaca, vi dico che ho 27 anni e quel tetto sicuro mi si rivela ogni giorno come un cimitero, che il mio letto caldo mi appare una tomba, che mi risucchia via la linfa vitale, i sogni, i desideri, le aspirazioni. “Voglio fare la scrittrice”, mi dico. “Ma a che serve? Non sarò mai come Kafka, anche se mi sento come lui ogni giorno di più”. “Voglio fare la regista”, fantastico. “Ma a che scopo? Non ho le possibilità economiche per diventare il nuovo Nolan”. “Voglio suonare sui palchi più grandi del mondo”, sogno. “Ma come? Non ho le conoscenze giuste; per queste cose devi essere qualcuno.”
Non ho risposte per nulla. Non ho amici, tranne una. Si chiama Apatia, la conoscete anche voi? È meschina, a volte. È un’amicizia tossica, quella tra me e lei, ma non posso farne a meno. Tutte le volte che provo a fare un piccolo passo, a salire un gradino per entrare a far parte (una volta per tutte) del mondo, la burocrazia e la generazione dei padri mi chiudono la porta in faccia senza neanche darmi il tempo di parlare; così torno a casa e lei è lì ad aspettarmi. Mi fa cenno di sedermi accanto a lei, sul mio letto-tomba, e mi sussurra all’orecchio: “Hai visto? Te l’avevo detto. Resta qui, è più sicuro. È più caldo. Non provarci ancora, lo sai che fa male.”
Fa male, sì. Fa male provarci. Ma mi dico che fa male anche non farlo. Un tale, un certo Bradbury, una volta disse: “Salta, e mentre cadi lascia che ti spuntino le ali”. Mi dico che erano altri tempi, anche se non è vero. Mi dico che nessuno ha mai provato quello che provo io.
Però. Però. Però mi dico che se ho 27 anni e ho l’animo così dannato (quante contraddizioni, eh?), se ho 27 anni e Kurt Cobain aveva la mia età quando stava diventando la leggenda del grunge, allora forse neanche io ho molto tempo. E allora mi dico che forse (forse) l’unica cosa che potrei fare è lasciare un segno, un’impronta, qualcosa che possa fare in modo che nessun altro arrivi a provare ciò che provo io ora. E devo farlo prima che scada il tempo, prima che torni la mia amica a chiedermi di andare in quel posto in cui tutto tace e niente fa male. Devo farlo prima di decidere di seguirla in quel posto. Così magari (magari) potrò scegliere di non volerci più andare. Potrò scegliere di troncare quell’amicizia. Potrò scegliere. Potrò alzarmi dal letto senza chiedermi perché l’ho fatto.
Ed ecco il mio appello a tutti voi. Ho poco tempo, ragà. Forse ne avete poco anche voi. Ho bisogno di lasciare un segno. E voi? Avete voglia di scegliervi il destino, piuttosto che rassegnarvi ad esso? Avete voglia di sentirvi importanti, necessari, indispensabili? Avete voglia di fare rete, di fare cultura, di creare un posto per dannati in cui tutto ciò che fa fremere l’anima prende vita in questo paese silenzioso? Avete voglia di fare casino, di ribellarvi, di prendere il vostro io interiore e strattonarlo e metterlo lì dove dovrebbe essere?
Per far fuori la mia amica, ho bisogno di appassionati viscerali come voi. Di musica, cinema, teatro, manga, design, letteratura.
Apatia continua a chiamarmi ininterrottamente, ha capito che non voglio risponderle. Per favore, se dovesse chiamare voi, fatemelo sapere. Così la facciamo fuori. Insieme.
Contattatemi al numero 3804744408 appena sentirete che il vostro mondo interiore sta per esplodere.
Martina D’Elia